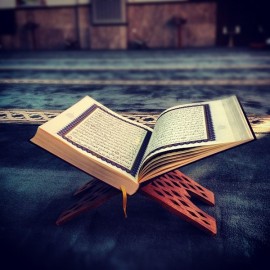Non è così semplice, come potrebbe apparire a prima vista, comprendere il senso del digiuno (sawum) nelle tradizioni musulmane. L’islam lo considera uno dei suoi cinque “pilastri” (arkan), insieme alla confessione di fede, la preghiera, l’elemosina e il pellegrinaggioalla Mecca.
Anche solo per averne un quadro accessibile, con le dovute semplificazioni per il presente contesto, bisogna individuarne le origini nel Corano, che presenta almeno un passo emblematico, relativo alla vergine Maria e vari testi di carattere legislativo in materia. Le successive tradizioni musulmane si possono individuare nella linea delle grandi scuole giuridiche della tradizione dei sunniti, con speciale riferimento alla scuola shafiita e ad Al-Gazali, senza dimenticare le prescrizioni shiite. Infine, è interessante, soprattutto per il mondo occidentale e cristiano, prendere in considerazione qualche aspetto delle tradizioni sufiche, per quanto tenute in considerazione dagli shiiti, ma scarsamente dai sunniti.
Le tradizioni sufiche sul digiuno possono avere uno speciale riferimento alla persona di Gesù, ma è bene aver chiaro quanto in esse sia diversa l’identità di Gesù rispetto a quella che ne ha le fede cristiana. Solo in questi termini è possibile capire cosa effettivamente voglia dire la dichiarazione conciliare sulle religioni non cristiane Nostra Aetate al paragrafo 3 §§ 859-860, dedicato ai musulmani, prende in considerazione il digiuno da loro praticato. In questa luce si comprenderà meglio il senso della prassi abbastanza recente, invalsa nella chiesa cattolica italiana, di inviare, attraverso il pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, un messaggio di felicitazioni in occasione della conclusione del digiuno musulmano del mese di ramandan presso le comunità musulmane presenti in nel nostro paese.
Il digiuno dei musulmani, dalle origini preislamiche alle sue formulazioni coraniche
Il termine sawum, in origine significava essere immobile; il significato di digiuno poté provenire dall’uso giudeo-aramaico e siriaco, quando Muhammad conobbe meglio questa pratica a Medina; è il senso acquisito dalla parola araba nelle sure medinesi.
La pratica del digiuno era nota alla Mecca, prima di Muhammad. I hunafa’ (cfr. hanif, monoteista come Abramo, secondo la tradizione coranica) verosimilmente osservavano questa pratica religiosa; tra le sure meccane, in 19,26 una voce fa dire a Maria: Ho fatto voto di digiuno al Misericordioso, perciò oggi non parlo con nessuno. Muhammad probabilmente aveva saputo che il silenzio era un aspetto del digiuno cristiano.
Nel secondo anno dell’egira (= la migrazione di Muhammad a Medina nel 622), secondo l’unanimità delle tradizioni musulmane, la rivelazione della sura 2,183-185 sostituì il digiuno di ‘ashura’ (il 10 del mese di muharram), praticato dai gruppi ebraici a Medina il giorno dell’espiazione (Lv 16,29) dal tramonto del sole al tramonto del sole, con quello di ramadan, forse per via del carattere particolarmente sacro del mese di ramadan fin dall’epoca pre-islamica.
Il musulmano pio, uomo e donna, è così caratterizzato in sura 33,35: 35In verità i dati a Dio e le date a Dio, i credenti e le credenti, i devoti e le devote, i sinceri e le sincere, i pazienti e le pazienti, gli umili e le umili, i donatori di elemosine e le donatrici, i digiunanti e le digiunanti, i casti e le caste, gli oranti spesso e le oranti, a tutti Iddio ha preparato perdono e mercede immensa.
Le prime disposizioni sul digiuno musulmano sono indicate in sura 2,183-185: 183O voi che credete, vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a coloro che vi hanno preceduto, nella speranza che voi possiate divenir timorati di Dio, 184per un determinato numero di giorni; ma chi di voi è malato o si trovi in viaggio, digiunerà in seguito per altrettanti giorni, Quanto agli abili che lo rompano, lo riscatteranno col nutrire un povero. Ma chi fa spontaneamente del bene, meglio sarà per lui; il digiuno è un’opera buona per voi, se lo sapeste! 185E il mese di Ramaḍ̣ān, il mese in cui fu rivelato il Corano come guida per gli uomini e prova chiara di retta direzione e salvazione, non appena ne vedrete la nuova luna, digiunate per tutto il mese, e chi è malato o in viaggio digiuni in seguito per altrettanti giorni. Iddio desidera agio per voi, non disagio, e vuole che compiate il numero dei giorni e che glorifichiate Iddio, perché vi ha guidato sulla retta via, nella speranza che gli siate grati.
Indicazioni sulla pratica del digiuno nel mese ad esso consacrato compaiono ancora in sura 2,187: 187V’è, permesso, nelle notti del mese del digiuno, di accostarvi alle vostre donne: esse sono una veste per voi e voi siete una veste per loro. Iddio sapeva che voi ingannavate voi stessi, e s’è rivolto miserdicorde su di voi, condonandovi quel rigore; pertanto ora giacetevi pure con loro e desiderate liberamente quel che Dio vi ha concesso, bevete e mangiate, fino a quell’ora dell’alba in cui potrete distinguere un filo bianco da un filo nero, poi compite il digiuno fino alla notte e non giacetevi con le vostre donne, ma ritiratevi in preghiera nei luoghi di orazione. Questi sono i termini di Dio, non li sfiorate. Così Iddio dichiara i suoi Segni agli uomini, nella speranza che essi lo temano.
In vari casi il digiuno è prescritto nel Corano come pratica sostitutiva, di fronte all’impossibilità di adempiere ad altre prescrizioni rituali o legali. In sura 2,196 il digiuno per alcui giorni è prescritto come pratica sostitutiva in caso di impossibilità di adempiere il pellegrinaggio alla Mecca: 196Compite il pellegrinaggio e la visita ai luoghi santi per amore di Dio, ma se ne siete trattenuti, andranno bene in cambio le offerte che potrete con facilità inviare, e, finché l’offerta non sia giunta a destinazione, non radetevi la testa. Se però qualcuno di voi è malato o ha un inconveniente alla testa, dovrà riscattare l’obbligo con un digiuno, o con un’elemosina o dei sacrifici. Quando siete al sicuro, chi profitta della visita per fare il pellegrinaggio, farà quelle offerte che potrà e se non gli riesce, digiunerà tre giorni durante il pellegrinaggio e sette al ritorno, il che fa dieci giorni completi. Questo è d’obbligo per chi non abbia la famiglia presente nel Sacro Tempio, ma temete Iddio e sappiate che Iddio con violenza castiga.
In sura 4,92 il digiuno di 2 mesi è prescritto in sostituzione dell’ammenda da pagare in caso di omicidio preterintenzionale: 92Non è ammissibile che un credente uccida un credente, altro che per errore; e chi uccide un credente per errore, espierà liberando uno schiavo credente e consegnando il prezzo del sangue alla famiglia dell’ucciso, a meno che non glielo condonino. Se poi la vittima appartiene a una gente a voi ostile, ma è credente, l’uccisore libererà uno schiavo credente. Se invece l’ucciso appartiene a una gente che ha un patto con voi, l’uccisore dovrà pagare il prezzo del sangue alla famiglia dell’ucciso e liberare uno schiavo credente. Chi non ha mezzi di far questo digiunerà per due mesi consecutivi come penitenza impostagli da Dio; ché Dio è sapiente e saggio.
In sura 5,89 il digiuno di 3 giorni è prescritto in caso di impossibilità a far fronte agli obblighi per espiare la violazione volontaria di un giuramento fatto in precedenza: 89Dio non vi riprenderà per una svista nei vostri giuramenti, bensì vi riprenderà per aver concluso giuramenti che poi avete violato: in tal caso l’espiazione sarà il nutrire deici poveri con cibo medio di cui nutrite le vostre famiglie, o il vestirli, o l’affrancamento di uno schiavo. Chi non troverà i mezzi di far questo, digiuni tre giorni. Questa è l’espiazione per aver violato i vostri giuramenti quando vi sarete impegnati.Mantenete dunque i vostri giuramenti quando vi sarete impegnati! Così Iddio vi dichiara i suoi segni affinché per avventura gli siate riconoscenti.
In sura 5,95 il digiuno è prescritto in caso di impossibilità a far fronte agli obblighi per espiare la violazione dello stato sacrale, cioè durante i riti del pellegrinaggio: 95O voi che credete! Non uccidete selvaggina trovandovi in stato sacrale. Chi di voi la ucciderà intenzionalmente,la pena che dovrà pagare, in forma di sacrificio da portare alla Ka‘aba, sarà un animale del suo gregge equivalente a quello dalui ucciso, e ne giudicheranno due uomini giusti tra voi; oppure per espiazione dovrà nutire un povero o fare espiazione equivalente in forma di digiuno, perché il trasgressore gusti il danno che viene dal suo atto. Dio perdona il passato ma Dio prenderà vendetta del recidivo,perché Dio è vendicatore possente.
In sura 58,3-4 il digiuno di 2 mesi consecutivi è prescritto in caso di impossibilità a far fronte agli obblighi per espiare da parte del marito il ripudio troppo sbrigativo della moglie, rimangiato successivamente: 3Coloro che ripudiano le loro mogli dicendo: “Sii per me come il dorso di mia madre!” e poi tornano su quanto hanno detto, s’abbino per ammenda l’affrancamento di uno schiavo, prima di accostarsi ad esse di nuovo. Di questo Iddio vi ammonisce: liberino uno schiavo prima di riprendere i rapporti coniugali. Siete esortati a far ciò. Allah è informato di quello che fate. 4E colui che non ne abbia i mezzi, digiuni [allora] per due mesi consecutivi prima di riprendere i rapporti coniugali. E chi non ne abbia la possibilità nutra sessanta poveri. Ciò [vi è imposto] affinché crediate in Allah e nel Suo Inviato. Questi sono i limiti di Allah. I miscredenti avranno un doloroso castigo.
Aspetti delle successive tradizioni musulmane
Per una più accessibile esposizione della materia, è bene distinguere fra la tradizione sunnita e shiita, e tra il digiuno obbligatorio del ramadan e i digiuni supererogatori. Uno spazio specifico va dedicato all’insegnamento di Al-Gazali in materia, il quale cercò di ricomporre all’interno della tradizione sunnita quanto poteva essare recuperabile del sufismo.
Il digiuno del ramadan nella tradizione sunnita
La scuola shafiita (secoli V-XI) stabilisce come digiunare e chi è obbligato al digiuno. Ai sensi della legge, il digiuno consiste nell’astenersi da quanto lo romperebbe, in virtù di un’intenzione (niyya) particolare; chi digiuna dev’essere musulmano, disporre delle sue facoltà mentali, e se si tratta di una donna non dev’essere contaminata dal sangue. A queste condizioni il digiuno è valido e vi sono obbligati tutti gli adulti in grado di farvi fronte; l’intenzione dev’essere formulata prima dell’alba di ogni giorno, ma talvolta si può formulare l’intenzione per tutto il mese. Rompe il digiuno quanto delle sostanze terrestri, percepibili e che si possano evitare, entra nel corpo: perché avvenga una rottura del digiuno occorre la volontarietà, la conoscenza e la libera volontà.
È raccomandato a chi digiuna di prendere “il pasto di rottura del digiuno” appena sia convinto che il sole è tramontato, e il pasto dopo mezzanotte il più tardi possibile; di astenersi da parole sconvenienti o malevoli; di astenersi da azioni capaci di suscitare le passioni in sè stesso o negli altri; di non farsi applicare ventose che facciano uscire sangue e cose che facciano sanguinare; di recitare il Corano per sé e per gli altri; di osservare il ritiro durante il mese di ramadan. Al-Gazali (1058-1111) vi aggiunge il dovere di assistere il prossimo.
L’obbligo del digiuno durante il mese di ramadan è il quarto pilastro dell’islam; chi ne nega il carattere obbligatorio è un apostata, eccettuato il neo-convertito o chi non ha frequentato gli ulema. Chi senza valida ragione non osserva il digiuno dev’essere imprigionato. L’obbligo generale del digiuno comincia il 1 ramadan, dopo il 30 shaban, o dopo il 29 se il kadi ha accettato la testimonianza di un solo testimone degno di fede che dichiarava di aver visto la luna nuova; l’inizio del ramadan dev’essere annunciato alla gente secondo il costume locale (colpo di cannone, luci, ecc.). Il completamento dei giorni di ramadan, in cui non si è digiunato, dev’essere adempiuto il più presto possibile, ma non in un giorno in cui il digiuno sia proibito, né in un giorno già di per sé consacrato al digiuno. Si distingue la grande dalla piccola compensazione. Alla prima è tenuto chi ha rotto il digiuno con atti sessuali; chi si è reso colpevole di omicidio; chi ha pronunciatola formula sbrigativa di ripudio della moglie senza farla seguire dal ripudio vero e proprio; chi ha trasgredito un giuramento valido. La piccola compensazione è dovuta quando si è nella condizione di trarre vantaggio dalla facilitazioni previste in casi in cui non ci sarebbe questione di digiuno. Nei casi di grande siccità l’imam, secondo la legge, può prescrivere cerimonie particolari comprendenti un digiuno (3 giorni).
La legge prevede alleggerimenti del digiuno in vari casi: le persone di una certa età (40 anni gli uomini; per le donne non è precisata) e i malati condannati, se non possono digiunare, sono autorizzati a dispensarsene, senza essere tenuti alla decisione del giudice nel caso che manchi; c’è una compensazione sostitutiva per ogni giorno di digiuno mancato. Quando le donne incinte o le nutrici temono un danno personale digiunando, la rottura del digiuno è per loro un obbligo, pur essento tenute alla sentenza di un giudice. I malati non condannati, o chi soffre la fame e la sete possono rompere il digiuno sotto condizione di una sentenza di un giudice; se qualcuno è in pericolo di morte o di perdere un membro, la rottura del digiuno è obbligatoria. Chi è in viaggio da prima dell’alba può rompere il digiuno in caso di bisogno, ma non se è partito durante il giorno; in caso di pericolo di morte, la rottura del digiuno è obbligatoria; bisogna che il viaggio duri almeno 2 giorni; ma in questo caso c’è la sentenza del giudice. Chi deve compiere avori gravosi è tenuto alla formulazione dell’intenzione durante la notte, ma può rompere il digiuno in caso di necessità.
Quando cessano i motivi di alleggerimento del digiuno, è conforme alla sunna digiunare per il resto del giorno.
Posso ricordare, a proposito del digiuno di ramandan, una prassi locale di fatto in vigore tra il 1974-1980 presso il villaggio arabo di Abudìs in Palestina, presso Betania, poco distante da Gerusalemme. La comunità musulmana locale era composta anche da molti uomini che lavoravano presso datori di lavoro ebrei nella città di Gerusalemme: allora non c’era ancora il famigerato muro e, pur tra i controlli a volte pesanti della polizia israeliana, non c’erano le attuali difficoltà per operai e dipendenti arabo-musulamani di andare e venire a e da Gerusalemme per il lavoro quotidiano. D’altra parte, il mese di ramadan, sempre caratterizzato da un caldo notevole a quella latitudine, costituiva un onere sovente impossibile per questi lavoratori arabo-musulmani sotto maestranze israeliane; i ritmi lavorativi ne risentivano troppo e la necessità di lavorare per le maestranze e i dipendenti era fuori discussione. Inoltre, i lavoratori arabo-musulmani, rientrando in famiglia anche prima del tramonto, si sentivano a disagio, perché i loro familiari praticavano correttamente il digiuno di ramadan, mentre loro erano costretti a frequenti deroghe o non praticare affatto il digiuno. Perciò, allo scopo di affrontare questo penoso problema di coscienza, i capifamiglia della locale comunità musulmana di Abudìs decisero di rivolgersi a un religioso sacerdote cristiano italiano, ancora abbastanza giovane, che parlava correntemente l’arabo e che godeva di grande stima anche presso la comunità musulmana del posto, affinché li consigliasse moralmente e spiritualmente su come gestire accettabilmente l’obbligo del digiuno del ramadan. E la cosa funzionò.
I digiuni supererogatori
Il digiuno volontario o supererogatorio è raccomandato; per una donna può avvenire solo con l’autorizzazione del marito; può essere rotto senza restrizioni; l’intenzione può essere formulata fino a mezzogiorno e non dev’essere necessariamente esplicita,anche se taluni la ritengono auspicabile in alcuni casi. Sono raccomandati a chi debba digiunare per compensazione i 3 giorni durante il pellegrinaggio alla Mecca e i 7 giorni dopo, scegliendo preferibilmente le ricorrenze del 7o,8o e 9o del pellegrinaggio alla Mecca. Per il digiuno volontario di 6 giorni del decimo mese dell’anno lunare musulmano, si scelgono preferibilmente i 6 susseguenti la festa; altri digiuni volontari sono segnalati in lunedì e giovedì in prossimità di tre speciali ricorrenze. È proibito infatti digiunare nei giorni di grandi feste, gli ultimi 3 giorni del pellegrinaggio alla Mecca, e per una donna quando ha le mestruazioni, come in determinati casi di pericolo incombente; è biasimevole digiunare venerdì, perché si distoglie l’attenzione dagli obblighi specifici di questo giorno; il sabato e la domenica perché ebrei e cristiani li festeggiano.
Il digiuno nella tradizione shiita
L’intenzione non è considerata un pilastro per il digiuno, che non è rotto fumando; è proibito bestemmiare la parola di Dio, del Profeta (Muhammad) o degli imam shiiti; l’uomo e la donna colpevoli di relazioni sessuali durante il digiuno del ramadan sono fustigati la prima volta e passibili di morte se recidivi. Il digiuno non è richiesto per un malato se il medico non l’autorizza; per le donne incinte la dispensa dal digiuno è entrata in vigore solo negli ultimi tempi; non si richiede il digiuno a chi viaggia, che però deve compensare. Il digiuno volontario può cominciare prima di mezzogiorno; nella tradizione shiita, oltre ai giorni raccomandati in quella sunnita, si aggiungono quelli specifici delle grandi ricorrenze shiite.
L’insegnamento di Al-Gazali sul digiuno
All’inizio di una sua specifica opera in materia, Al-Gazali mostra in quale considerazione sia tenuto il digiuno da Dio: è un’attività passiva, di cui solo Dio è testimone; è un mezzo per dominare il nemico di Dio, perché le passioni umane, ausiliarie di Satana, prosperano quando si mangia e si beve: il digiuno è la porta del servizio di Dio. Dopo aver elencato le disposizioni relative al digiuno, Al-Gazali dichiara che non ne costituiscono l’essenziale; vi distingue tre gradi: il primo, giuridico; il secondo, sufficiente a ogni persona pia, consiste nel tenersi fuori dal peccato e da tutto ciò che distoglie da Dio gli organi dei sensi del corpo, poiché la sottomissione delle passioni è lo scopo specifico del digiuno e non l’astinenza in quanto tale; il terzo grado è dei profeti, dei “sinceri” e così via, che il digiuno separa da tutti i desideri terreni. Al-Gazali parla anche del digiuno volontario, ma, soprattutto, biasima il “digiuno perpetuo”, praticato in modi diversi dai mistici del suo tempo: la rottura del digiuno è obbligatoria in alcuni giorni dell’anno e desiderabile in sé.
Nell’opinione corrente odierna molto diffusa, il digiuno del ramadan in particolare è l’espiazione più appropriata delle colpe commesse durante l’anno, così che in generale è ben osservato, anche se più o meno strettamente.
Gesù nelle tradizioni sufiche sul digiuno
L’insegnamento di Al-Gazali permette di inquadrare correttamente il sufismo
all’interno della tradizione musulmana sunnita, largamente predominante nell’islam mondiale. Le tendenze mistiche delle tradizioni e delle scuole sufiche non hanno affatto piena cittadinanza nell’islam sunnita, godendo invece di un maggior credito in quello minoritario shiita. Ciò va ribadito a fronte di malintesi o di mode correnti nella cultura occidentale odierna, di matrice cristiana o anche semplicemente laica. Se è inevitabile, per un cristiano che si accosti all’islam, passare per il pensiero e l’opera del grande islamologo francese L. Massignon, appassionato studioso del mistico musulmano Hallaj, così da assimilarne la lezione di empatia necessaria per lo studio dell’islam, è altrettanto indispensabile sapere che il sufismo non può essere considerato la vera identità dell’islam. Ciò smentirebbe quanto esplicitamente almeno l’islam sunnita pensa e dice di sé stesso. Ancor meno raccomandabili sono interpretazioni mistico-gnostiche dell’islam e del sufismo, come quelle emergenti in altri autori occidentali moderni e contemporanei. Tutto ciò dimostra soltanto che il volto sufico dell’islam, per superficiale o distorta comprensione dall’esterno, è quello ritenuto più congeniale alla cultura occidentale ed eventualmente cristiana. Quando l’accentuazione sulle analogie fra tradizioni sufiche e tradizioni cristiane proviene da esponenti musulmani, o da neo-convertiti dal cristianesimo all’islam, non si possono escludere finalità di proselitismo; in nessun caso possono essere considerate rappresentative dell’islam maggioritario mondiale.
Nell’islam i testi del Corano sono parola di Dio, assolutamente autorevoli; gli scritti appartenenti alla Sunna, una delle fonti del diritto islamico, vengono in secondo luogo; godono invece di autorità relativa i testi delle Vite dei profeti; i testi mistici, delle tradizioni sufiche, non hanno alcun valore normativo, godendo soltanto di stima all’interno di quelle correnti.
Nell’islam, le tradizioni sufiche hanno largamente praticato il digiuno, ben oltre a quello obbligatorio del ramadan, fino a indicare nel “digiuno perpetuo” un ideale. In particolare, le testimonianze dei sufi (dal’VIII al XIX secolo) guardano alla persona di Gesù come a un profeta, sapiente, operatore di miracoli, maestro che illumina quanti incontra sulla propria strada, un credente, modello di sottomissione (islam), musulmano perfetto: il suo insegnamento riguarda il fare e il mettere in pratica, il pregare. Per loro Gesù è un santo asceta, mistico, che raccomanda povertà, sobrietà, il guardarsi dal mondo: in ciò la tradizione sufica si accosta in parte a quella monastica cristiana, ma si distacca completamente da quella musulmana sunnita. Nella tradizione sufica Gesù è connesso al fine ultimo della storia umana, alla fine del mondo, a ciò che sarà oltre la morte; anche se continua a essere chiamato “cristo-messia”, nell’islam questi termini hanno un’accezione molto diversa da quella data loro nel Nuovo Testamento e nelle tradizioni cristiane.
È invece più verosimile che l’islam e le tradizioni sufiche abbiano in qualche modo contrapposto al Gesù delle definizioni teologiche largamente imbevute di terminologie filosofiche delle correnti cristiane perennemente conflittuali tra loro dei secoli V-VIII, un Gesù più “comprensibile”, più “semplice”, certamente congeniale all’islam. Sotto il profilo letterario, si rileva che negli aforismi sufici, attribuiti a Gesù sul digiuno, quelli di più evidente ispirazione evangelica risalgono a i primi secoli dell’egira; allontanandosi da questa fase iniziale i nuovi aforismi di Gesù sul digiuno nelle tradizioni sufiche dipendono sempre meno da tradizioni evangeliche.
Ibn Al-Mubarak (736-797) conosce le tradizioni su Gesù connesse al Vangelo di Matteo, di cui richiama quella sul non ostentare esternamente la pratica del digiuno (cfr. Mt 6,16-18). Abu Rifaa Al-Fasawi (morto nel 902) ricorda di Gesù il suo trascorrere giorni soffrendo la fame. Al-Samarqandi (forse morto nel 983) traccia una quadro di Gesù “che digiunava sempre”, mentre sua madre Maria digiunava due giorni di seguito, rompendo poi il digiuno per due giorni; in altro un detto attribuisce a Gesù un “colorito alterato per la fame, labbra essicate per la sete”. Abu Talib Al-Makki (morto nel 998) riferisce che anche gli apostoli digiunavano come Gesù, senza però riuscire a compiere i suoi prodigi, perché non ne avevano lo stesso distacco dal mondo. Al-Thalabi (morto nel 1035) riporta una complesso amalgama di tradizioni su Gesù, tra le quali una lo presenta mentre invita i figli d’Israele a digiunare per 30 giorni, al termine dei quali, su richiesta dei digiunatori, Gesù prega Dio perché faccia scendere una mensa imbandita, dalla quale tutti poi mangiano. Abu Nuaym Al-Isfahani (morto nel 1038) riferisce un detto di Gesù sulla necessità anche del digiuno per poter conoscere Dio; in un altro aforisma, riportato dallo stesso autore, Gesù afferma che il suo “condimento è la fame”. Al-Gazali (1058-1111) riferisce, tra gli altri, un detto di Gesù sul premunirsi dalle donne mediante il digiuno e la preghiera; in un altro lungo aforisma, attribuito a Gesù, lo stesso autore parla di un’invettiva di Gesù, che rielabora largamente varie frasi del Vangelo diMatteo, contro i sapienti malvagi, i quali per amore della mondanità, praticano malamente il digiuno, la preghiera e l’elemosina, pilastri dell’islam. Ibn Asakir (1105-1176) riferisce un aforisma attribuito a Gesù, secondo il quale “Chi prega e digiuna senza abbandonare i peccati è iscritto nel regno di Dio come bugiardo”. Ibn Arabi (1165-1240) riporta un aforisma di Gesù sul “digiuno dal mondo”, analogo all’apocrifo cristiano del Vangelo di Tommaso 27, noto anche a Clemente di Alessandria, ma anche a qualche altro esponente della tradizione islamica.
Il Concilio Vaticano II e il digiuno praticato dai musulmani
I documenti del Concilio Vaticano II presentano quattro diversi generi letterari del linguaggio del magistero della Chiesa: la “costituzione dogmatica”, che impegna la fede dei cristiani; la “costituzione dogmatica pastorale”, che non si caratterizza per nuovi pronunciamenti dogmatici, ma per un nuovo orientamento pastorale; il “decreto”, che dà direttive di comportamento, oltre che indicare prassi disciplinari; la “dichiarazione”, che affronta temi di attualità, anche se non impegna ancora direttamente né in materia di fede, né di vita pratica. Ciò che i documenti conciliari dicono sui musulmani appartiene in modesta misura a una “costituzione dogmatica” (cfr. Lumen Gentium 16), mentre per lo più è formulato in una “dichiarazione” (Nostra Aetate 3).
Il Concilio Vaticano II ha cercato di indicare una strada percorribile per i rapporti islamo-cristiani, nonostante una storia fatta di equivoci, incomprensioni e scontri. Con Nostra Aetate 3 e la più breve formulazione di Lumen Gentium 16 (che non presenta aspetti di natura dogmatica relativamente ai musulmani) i padri conciliari hanno voluto toccare alcuni aspetti delle credenze e delle pratiche religiose dei musulmani essenzialmente per quanto possono presentare di compatibile rispetto alla fede e alla tradizione cattolica, escludendo quindi garbatamente quanto invece è più specifico in ordine all’islam, ma incompatibile con la fede cristiano-cattolica. D’altra parte, gli stessi padri conciliari non si sono pronunciati sui temi più cruciali dell’islam (che non è mai nominato nei testi del Vaticano II come religione), come Muhammad, il Corano, la “umma” (comunità islamica dei credenti) e così via. Sotto questo profilo, i loro silenzi sono anche più significativi delle affermazioni esplicite. Nessuna delle formule poi correnti nell’epoca post-conciliare, come le “tre religioni monoteistiche”, “abramitiche”, “profetiche”, “rivelate” o “del libro”, in riferimento a ebraismo, cristianesimo e islam, si devono considerare come appartenenti ai testi conciliari, né al loro spirito: rispetto ad essi, presentano ambiguità e approssimazioni inaccettabili per la fede cristiano-cattolica. La sorvegliata cautela teologica del linguaggio conciliare sui rapporti con i musulmani intende invece scommettere, per così dire, che, nonostante la consapevole distanza delle posizioni teologiche di partenza (cfr. Nostra Aetate 3 § 859), sia possibile compiere insieme una strada di collaborazione operativa (cfr. Notsra Aetate 3 § 860). Per questa ragione, sottolineando solo qualche tratto parzialmente affine tra credenze e osservanze dei musulmani con la fede e morale cattolica, il Concilio tende una mano amichevole verso interlocutori, con i quali i dialogo in passato non è stato mai facile, pur non essendo mancato qualche spiraglio di maggiore apertura.
Specificamente, a riguardo del digiuno, praticato dai musulmani, così si esprime nel contesto la dichiarazione Nostra Aetate 3 § 859, rilevando che <<[i musulmani] rendono culto a Dio soprattutto con la preghiera, le elemosine e il digiuno>>. In questa frase i padri conciliari richiamano 3 dei “pilastri” dell’islam, omettendone gli altri 2, cioè la confessione di fede e il pellegrinaggio alla Mecca, teologicamente rilevanti per gli aspetti di incompatibilità con la fede cristiano-cattolica. Dei 3 “pilastri” menzionati, anche i contenuti della preghiera dei musulmani presentano elementi dogmatici non compatibili con la fede cristiano-cattolica, mentre l’elemosina e il digiuno, in quanto adempimenti rituali, hanno minori implicanze dogmatico-rituali.
Mentre la tradizione sufica nelle propria spiritualità sul digiuno coinvolge la persona di Gesù, riducendone la portata e il significato in conformità con la teologia musulmana, il testo coranico (cfr. sura 19,26) coinvolge Maria come modello di coloro che digiunano; la tradizione sunnita, nelle scuola shafiita, ma anche la tradizione shiita, si occupano invece soprattutto di regolamentare la pratica del digiuno obbligatorio del ramadan e di quello volontario in altre occasioni; inoltre, il digiuno praticato dai musulmani ha anche funzioni di compensazione rispetto a colpe e inadempienze di varia natura.
Padre Giovanni Rizzi, Barnabita